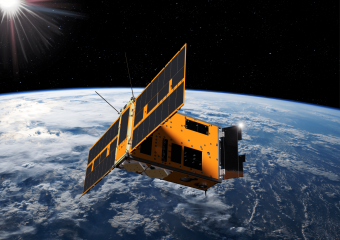L’articolo è stato pubblicato oggi su quotidiano L’Arena di Verona
E’ il più importante mausoleo dedicato a un singolo eroe della prima guerra mondiale. Tuttavia, non c’è un solo cartello che indichi e spieghi: per la tomba di Cesare Battisti, bisogna salire lassù, al Doss Trento, colle sulla riva destra dell’Adige.
E’ un monumento imponente, e non solo per la posizione riconosciuta a chi è morto per un sogno di Italia e di libertà. Sorge in alto sulla città, quasi una metafora fra la terra e il cielo riservata ai martiri, cioè alle persone comuni che in epoche e circostanze diverse pagano con la vita il proprio impegno per gli altri. Opera semplice e solenne come la figura dell’uomo che vi riposa, il più trentino degli italiani, il più italiano dei trentini. Eppure, non una scenografia particolare, né una bandiera tricolore, né un percorso storico-sentimentale preparano l’occasionale visitatore all’evento: entrare in un mausoleo nazionale che per impatto emotivo ricorda la tomba parigina di Napoleone a Les Invalides. Un modello classico dalla forma circolare, sedici colonne alte più di dieci metri. Un’opera che porta la firma dell’architetto e scenografo veronese Ettore Fagiuoli. Grandiosa e suggestiva, dunque.
Ma i visitatori si contano sulle dita di una mano: soltanto cinque il 5 settembre scorso. Imbarazzante, ma ovvio. Il maestoso simbolo non è promosso, organizzato, restaurato come dovrebbe. Il paragone è impietoso, se si pensa allo splendido percorso museale da poco inaugurato nella vicina Bolzano dall’architetto Ugo Soragni, direttore regionale dei Beni culturali e paesaggistici del Veneto, in accordo con la Provincia e con il Comune alto-atesini, per raccontare e valorizzare il contemporaneo Monumento alla Vittoria. Bolzano ha riscoperto la sua opera del 1928, Trento ne ha dimenticato la sua del 1935. Code per visitare la Vittoria, il deserto per il Mausoleo.
Eppure, i due monumenti dipendono dalla stessa amministrazione di tutela dello Stato. Ed entrambe le province hanno identica autonomia legislativa per agire d’intesa. Ma nei cent’anni della Grande Guerra l’eroe è di nuovo solo. Con l’erba alta. Con l’acqua della pioggia che non scorre, ma deturpa la struttura visitabile solo in parte. E fra due anni cadrà il secolo della morte di Battisti, avvenuta nel 1916 per capestro (significa strangolato e non impiccato come suol dirsi), da parte degli austriaci nella sua Trento. L’esecuzione di questo giornalista, geografo, politico e leader socialista di quarantun anni catturato in battaglia, doveva essere un brutale monito per tutti: ecco che vi succede, se scegliete di combattere da italiani, voi del territorio appartenente (allora) all’Austria-Ungheria.
“Evviva l’Italia, evviva Trento italiana!”, furono le sue ultime parole che ancora risuonano nella patria liberata. Liberata, ma immemore.