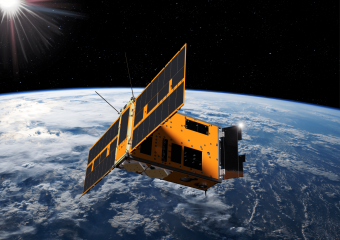Caro presidente del Consiglio Enrico Letta, capisco bene che in queste ore lei sia in ben altre faccende affaccendato. Ma so che lunedì prossimo lei sarà a Bolzano per benedire un presunto “accordo” sulla toponomastica in Alto Adige trovato fra il suo ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, e il presidente della giunta provinciale di Bolzano, Luis Durnwalder.
E allora, lei deve sapere che l’accordo che s’accinge a battezzare, in realtà è una proposta indecente. Perché ha l’obiettivo dichiarato di impedire che il prossimo 10 ottobre la Corte costituzionale si pronunci in modo definitivo sull’obbligo del bilinguismo nelle forme italiana e tedesca (e anche ladina) in Alto Adige. Come impedirlo? Inducendo il suo governo a ritirare il ricorso che il precedente governo-Monti aveva presentato alla Consulta contro una legge della Provincia di Bolzano che fa strage della dizione italiana nella toponomastica bilingue italiano-tedesca. Una bilinguità in vigore da quasi settant’anni: e l’Alto Adige fa parte dell’Italia da quasi un secolo. Dunque, il patrimonio culturale e linguistico italiano ha un valore consolidato e una valenza condivisa almeno quanto quello tedesco.
Lei dirà, presidente, quel che il ministro Delrio ha già detto per tranquillizzare, e cioè che l’intesa tra lui e quel furbacchione di Durnwalder (è già il secondo ministro “romano” che l’alto-atesino si beve: il primo fu Raffaele Fitto), salverebbe il bilinguismo. Tanto più che non mancherebbe il contributo attento del commissario di governo a Bolzano.
Ma il punto non è “salvare il salvabile” dei nomi italiani. Ciò che l’accordo nasconde (neanche troppo) è la concreta eliminazione di gran parte della forma italiana della toponomastica. Il 55 per cento dei nomi italiani secondo i primi calcoli che già circolano!
In Alto Adige, al contrario, si tratta di far rispettare il bilinguismo integrale e senza eccezioni originato dal lungimirante Accordo De Gasperi-Gruber del 1946. Bilinguismo obbligatorio ripreso sia dallo Statuto regionale del 1948, sia dallo Statuto provinciale e vigente del 1972 che, oltretutto, chiarisce: “L’italiano è la lingua ufficiale dello Stato”.
Lo Statuto, che è legge costituzionale, non può essere violato con un bilinguismo casuale (un po’ di nomi li lascio, un po’ li cancello). E meno che mai con forme di monolinguismo tedesco su cosiddetti “nomi storici”, che hanno sempre l’altrettanta e secolare forma storica italiana. Per non dire del grottesco criterio del “nome d’uso”, che si vorrebbe anch’esso introdurre in barba alle leggi e alla realtà della vita. E poi: perché mai dovrebbe essere Durnwalder o chi per lui a stabilire se io, cittadino italiano e del mondo, possa chiamare o no “Vetta d’Italia” la Vetta d’Italia?
Tutte cose incredibilmente contemplate in quest’accordo taglia-Italia. Che non rispetta nemmeno la volontà espressa da una recente e ampia mozione del Parlamento, perché viola l’Accordo De Gasperi-Gruber, infrange la bilinguità assoluta dello Statuto speciale e calpesta la Costituzione della Repubblica.
La toponomastica bilingue in Alto Adige non è una lotteria né un’acrobazia per politici mal informati. La toponomastica è un diritto inviolabile della persona. Invece qui, presidente Letta, si vuole impedire che in Italia un cittadino italiano (o chiunque al mondo) possa usare una dizione italiana per indicare un fiume, un bosco, un sentiero, una cima. L’esempio che le ho fatto della Vetta d’Italia è voluto, perché è uno dei tanti nomi che apertamente si rivendicano di voler abolire. Come se io le dicessi -tanto per fare un altro esempio- che lei, da domani, non potrà più dire, in italiano, “vado a fare una gita sul “Catinaccio”. E perché? Perché Durnwalder ha deciso che lei la gita potrà farla solo sul “Rosengarten”.
Stiamo parlando della stessa montagna: si rende conto della gravità inaudita del principio elementare e costituzionale infranto, cioè dell’obbligo monolingue d’usare la sola, esclusiva e perentoria dizione in tedesco per un certo ed elevatissimo numero di toponimi?
“Ma proprio il Catinaccio-Rosengarten nessuno vuole toccarlo”, le direbbe certamente Durnwalder. Il punto, però, è che nessuno deve poter toccare, cioè rendere “impronunciabile”, qualsiasi nome di luogo in italiano, piccolo o grande, famoso o sconosciuto, pre-latino o d’inizio Novecento che sia. Comunque, cent’anni di storia.
Su questa materia si sono già pronunciati tutti, e da decenni, e sempre all’insegna del più rigoroso bilinguismo: manca solo l’ultima parola della Corte costituzionale il 10 ottobre 2013. Sarebbe il colmo impedire anche a lei, anche alla Corte, di “parlare”, esattamente come si vuole vietare alla lingua di Dante di esprimersi in pieno per indicare i luoghi del cuore in Alto Adige, minuscoli o imponenti che siano.
Caro presidente, non un solo nome da abolire nella forma italiana, non un solo nome da abolire nella forma tedesca. Il bilinguismo integrale senza censure e senza sconti è l’unica scelta di ricchezza, di pluralità, di autentica “convivenza alla pari” che lo Stato ha il diritto-dovere di preservare in Alto Adige. Aggiungano l’inglese, lo spagnolo, l’arabo o il cinese ai nomi di luogo, se proprio vogliono innovare con lo sguardo al domani, anziché con la testa perennemente rivolta all’indietro. Ma l’italiano non si tocca e non si può toccare. Non facciano finta di non saperlo gli esperti della questione alto-atesina, a Roma e a Bolzano.
Mi domando, presidente, se lei, che rappresenta l’Italia, abbia capito l’importanza anche simbolica della posta in gioco. Che non è il “chissenefrega” di quattro nomi di montagna (e i nomi, peraltro, sono migliaia e migliaia). In ballo c’è il diritto alla parola, alla memoria, al futuro plurilingue che l’Italia ha costruito per l’Alto Adige con un’autonomia anche economica che non ha eguali al mondo. Ma un mondo senza più muri, né prepotenze. Dove il valore della libertà e della dignità non sono e non potranno mai essere “negoziabili” al mercato della peggiore politica.
L'articolo Caro Letta, lo sa che sta per firmare un atto indecente? sembra essere il primo su Formiche.